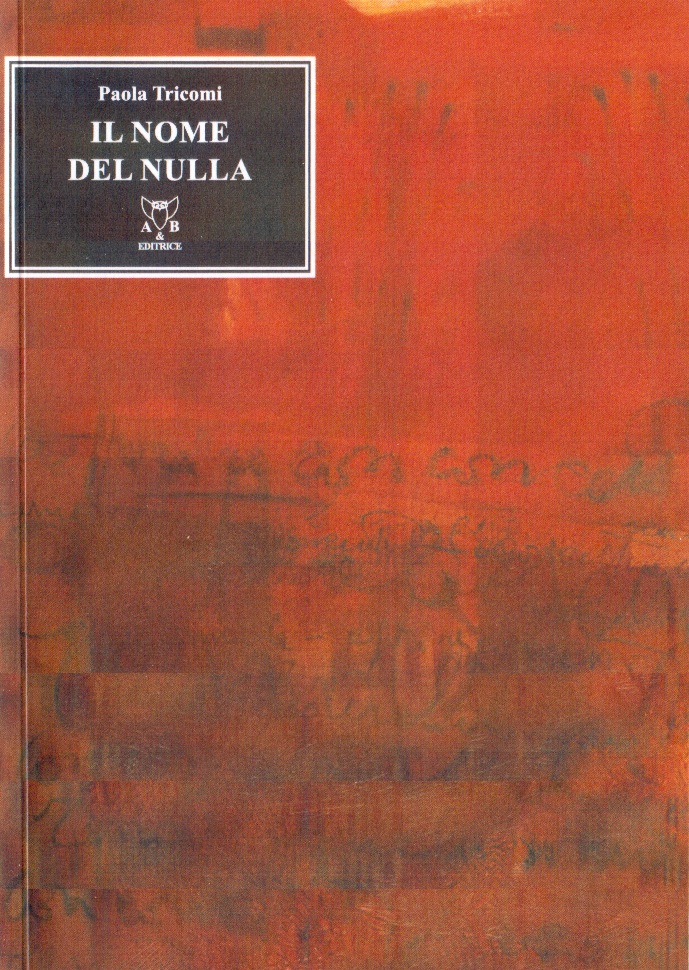 Studio Tablinum: per una lettura de “Il Nome del Nulla” di Paola Tricomi
Studio Tablinum: per una lettura de “Il Nome del Nulla” di Paola Tricomi
Lo sguardo rivolto verso l’interno, a quell’ “oscuro regno del nulla e del tutto” donde si dirama, nella totalità e nella complessità delle sue manifestazioni, ciò che ha nome di vita, essere, esistenza. Un segno chiaro del carattere già maturo di questa poesia è nella possibilità di cogliervi una notevole consonanza fra il livello del significante e quello del significato. La poesia di Paola Tricomi nasce dall’ascolto, scaturisce da un’attenzione continua ad ogni minimo palpito del cuore, di quello “thymos” che la poetessa stessa indica come serbatoio di una sorta di magma che è l’erompere dei moti dell’animo; al lettore essa chiede che si abbandoni alla musica che la pervade, e che le dona senso già prima che la mente del lettore elabori razionalmente i concetti e le immagini. La lezione della poesia novecentesca vi è presente non meno di quella antica, anzi –direi- intrinsecamente fusa con essa. Segno di questa sintesi, la presenza di un repertorio di immagini ricco e vario, che tesse un ordito limpido e scintillante (“a maglie d’oro”, per usare la medesima espressione che l’autrice usa a proposito dell’anima) , su cui s’innesta una tramatura di riflessioni sul senso dell’essere che situano la sua poesia al crocevia fra quella di carattere gnoseologico di ascendenza leopardiana e montaliana e quello specifico carattere della poesia del primo novecento , che ama accostare “immagini lontane, senza filo”, come scrive Ungaretti, per portare alla luce aspetti inediti e spesso contraddittori dell’umano vivere. Di qui discende una certa impressione di ermeticità che una prima lettura dei versi potrebbe dare. Si tratta in realtà di conoscere non con la sola ragione né col solo sentimento, ma di unire tutte le facoltà come antenne multiple e convergenti verso il medesimo obiettivo.
Lente cadenze di versicoli spesso monoverbali o quasi, a distillare il senso delle cose, e poi un’impennata improvvisa, una danza ritmata, poi allegra, poi pazza, poi furente e quasi bacchica: lo thymos che sente e scrive si muove agilmente ora dentro ora fuori di sé, disegnando un percorso dove la densità di senso si lascia scoprire solo attraverso un processo di scarnificazione, che porta all’essenziale, a una nudità algente e spaventosa come la verità, che questa poesia trova scavando impietosamente per gettare all’aria gli orpelli, il di più, l’inutile mistificante. Il vedersi vivere torna in questi versi non come un’uscita da sé, un’alienazione e un’estraneità che allontana le emozioni ed emarginandole riesce a vedere e a capire con maggiore lucidità; piuttosto, invece, si tratta di rimanere tutti dentro sé stessi, come concentrati e attenti, tutti tesi a percepire ogni accordo che il tempo scandisce, a cogliere ogni gesto, ogni mossa, tutti i “passi da copione” da recitare lasciandosi sul volto “la maschera ridente” nella quale, dall’interno appunto, lo sguardo scopre “buchi lasciati, spazi per guardare, vuoti profondi in occhi di carnevale”. Naturalmente, il tutto è lì a disposizione di chi ha occhi per vedere! Le lacrime della maschera sono dette “interne”, e sembrano quasi soffocate, o meglio lasciate scorrere nell’indifferenza, la stessa che avrà il pubblico della recita che è la vita, capace solo di applaudire ciò che si vede all’esterno.
La musica che accorda e intona questi versi è la medesima che , dopo la fase “entusiastica” –nel senso dionisiaco!- è capace di fare una pausa per accordare cuore e mente, e ascoltare le domande che quest’ultima si pone, e che introducono nel continuum musicale-emotivo di questa poesia delle pause meditative e riflessive. E poi, dopo altre evoluzioni di pensieri che l’autrice ha la singolare capacità di reificare , rendendoli quasi concreti e tattili oggetti ognuno percepibile ed esperibile dal lettore nel suo peso specifico, ecco prorompere il più rumoroso protagonista di questa poesia: il silenzio! Esso arriva e s’accampa quando dalla maschera, forse attraverso le fenditure e i buchi, la poetessa passa a trovare il volto, a fare la scoperta che fece trasalire Psiche quando vide il volto di Amore. Qui, tuttavia, nessun veto divino, almeno esplicitamente imposto. Resta una nenia, che incessante rompe il silenzio con l’urgenza delle domande di senso: “Chi tu mai fosti? Chi, d’essere, sarai?”. Nel secondo di questi versi si arriva quasi al puro divertissement verbale, al gioco fonico, nel rincorrersi delle varie voci del verbo oggetto dell’inesausta ricerca, quasi fosse un gioco di specchi che si perde all’infinito o una eco che finisce per saziarsi di sé stessa, senza compiacersene, nel turbinio di riflessioni su emozioni che conduce all’impossibilità di arrivare a una risposta che appaghi.
La direzione del movimento si sposta ancòra, e dallo spazio passa al tempo, e se ne può vedere la danza, si possono sentire tutte le variazioni ritmiche che attraversa nel suo scorrere inesorabile, che rende il passato come una casa troppo piccola per potervi abitare e al contempo disfa quei legami che davano senso all’andare e sicurezza al cuore, e scopre la solitudine del cammino. E una nuova mano guida per un mare tempestoso ma che si deve attraversare, perché è la vita stessa, e l’unica modalità per attraversarlo è abbandonarvisi, nella certezza che una mano ci culli. Il bisogno di sostituire alle certezze dell’infanzia una nuova certezza, di tenere un’altra mano erompe dal cuore come un bisogno puro e vero, e rivela la fragilità dell’umana natura, che torna – o forse resta- bambina anche, e forse ancor più e a maggior ragione- nell’età adulta, l’età delle maschere. Il bisogno di autenticità emerge naturalmente prepotente, e in questo magma di emozioni e istinto si leva improvvisa la voce che chiama in causa gli antichi, l’imperatore Marco Aurelio in particolare, celeberrimo regnante e filosofo, tutto teso alla ricerca di una onestissima virtù che chiede, esige impegno in prima persona, e forse chiede anche troppo –ma sempre in buona fede- a sé stesso, l’autarchia che la fragilità umana, splendidamente caduca, non sa attingere a nessuna fonte. Vorrei approcciare qui l’aspetto della presenza dell’antico nella poesia di Paola Tricomi: lungi dall’essere puramente esornativa ed erudita, essa si fa ora confronto vivo, inevitabile e imprescindibile con un’umanità di forte sentire che chiama, esorta, interroga, spinge al confronto, ora serbatoio lessicale cui si deve ricorrere perché dotato di una ricchezza e pregnanza di senso dalla quale, volenti o nolenti, non si può prescindere.
Un’attenzione particolare, nel perenne fluire delle cose che sono, è rivolta a ciò che resta, a quelle “crepe e cocci” che danno il titolo a una delle sezioni dell’opera. Sono piccole reliquie di un tempo impietoso, rimaste lì, nel silenzio, nel bianco, come tutto ciò che conta ed ha senso. Ciò che resta: e poco, questo è vero, ma è prezioso. Si scopre così il peso dei ricordi e il bisogno di una continuità, di ricomporre un ordine e di segnare un cammino chiaro e unidirezionale rimettendo a posto tutto quello che i ricordi per loro natura turbano e sconvolgono.
Il rincorrersi di suoni ha una certa frequenza: così in “Mie costellazioni”, dove si legge “Sogno boccoli d’oro, di intrecciarli fra le dita, di intrecciare intrecciare intrecciarmi inebriarmi…”, o in “Aurea memoria”, “di un animo che trascorre al trascorrere stesso” o in “Notturno”: “quel cielo ricurvo su sé ricurvo”. Significative anche le sequenze asindetiche di aggettivi, che conferiscono al dettato poetico la capacità di ritrarre compiutamente in pochi tratti degli oggetti di per sé impalpabili come gli attimi di cui il tempo è composto (“attimi/al secolare passo/cadenzato regolare armonico” in “Il presente del passato”) o la bellezza come effetto del potere della poesia in “Ti cerco”: Poesia, forse l’essenza ancora capace/di ricondurre alla bellezza limpida lucente lineare di un tratto, un contorno”. Ancora in “Monologo ad una sigaretta immaginaria” si legge “Prendere forma in ciò che da sempre si è desiderato essere e desiderare essere l’immagine che desiderava”.In “Farti, farmi una culla”, poi, tutto il testo andrebbe letto per apprezzare questo gioco di specchi, che è poi tuttuno col destino stesso del poeta: “una vita senza vita…dare forma al fumo, dal bianco al bianco…autentica finzione, alchimia…oppure vivere due più volte infinite in immagini moltiplicate di un tono più intenso planando nell’intus profondo a pulviscoli?”
Nella profondità dello scandaglio poetico che l’autrice fa scendere negli abissi del suo cuore, è interessante notare come, dal buio profondo dello thymos, ella sia capace di far affiorare sempre la luce (d’altronde, come scrive il prof. Savoca nella postfazione al volume, “luce” è il termine a più alta frequenza nella raccolta!).
 Pare che in questa lettura ci si muova prima dalla superficie verso il centro dell’essere, e poi al contrario: catabasi e anabasi che sono sapientemente incluse in una vera e propria struttura anulare che inizia e finisce con lo thymos, che parte dal desiderio di descrivere e arriva alla conclusione che il dolore non si può rendere all’esterno: solo l’inesausta ricerca ha senso: “Cercami sempre…e ci sarò”.
Pare che in questa lettura ci si muova prima dalla superficie verso il centro dell’essere, e poi al contrario: catabasi e anabasi che sono sapientemente incluse in una vera e propria struttura anulare che inizia e finisce con lo thymos, che parte dal desiderio di descrivere e arriva alla conclusione che il dolore non si può rendere all’esterno: solo l’inesausta ricerca ha senso: “Cercami sempre…e ci sarò”.
Elio Distefano
